 Che il mercato finanziario abbia bisogno di un rinnovamento esemplare non è un mistero. Da tempo, ormai, si parla quotidianamente di speculazioni nocive, titoli tossici, strumenti di investimento “alternativi” o “non convenzionali”, insolvenze e così via, per arrivare, immancabilmente, allo spauracchio delle Grande Crisi. Un po’ meno chiaro, purtroppo, è il modo concreto in cui questa trasformazione dovrà avvenire. E, soprattutto, nessuno sa spiegare come si farà a coinvolgere la Borsa dei “piani alti” nei costi della crisi: anche perché ogni riforma, dalla più banale, sembra non trovare spazio all’interno del far west finanziario.
Che il mercato finanziario abbia bisogno di un rinnovamento esemplare non è un mistero. Da tempo, ormai, si parla quotidianamente di speculazioni nocive, titoli tossici, strumenti di investimento “alternativi” o “non convenzionali”, insolvenze e così via, per arrivare, immancabilmente, allo spauracchio delle Grande Crisi. Un po’ meno chiaro, purtroppo, è il modo concreto in cui questa trasformazione dovrà avvenire. E, soprattutto, nessuno sa spiegare come si farà a coinvolgere la Borsa dei “piani alti” nei costi della crisi: anche perché ogni riforma, dalla più banale, sembra non trovare spazio all’interno del far west finanziario.
Ancora non è stato deciso, ad esempio, come e se verrà disciplinato il mercato dei cosiddetti credit default swaps, o CDS, contratti derivati sul rischio di credito. I CDS costituiscono la polizza assicurativa degli attori di borsa: chi acquista questi contratti, si assicura contro l’eventualità di un fallimento della società (o dello Stato) che le emette. L’investitore compra i CDS da società finanziarie terze, che risarciranno l’investitore dell’intera somma corrispondente alle obbligazioni assicurate in caso di default. L’unico problema è che le società venditrici di CDS non sono società assicurative ed inoltre sono in grado di garantire protezione anche a chi non detiene in portafoglio i titoli “garantiti” dal derivato.
Benché i CDS siano nati negli anni 90 come prodotto protettivo per creditori reali, il suo impiego speculativo è stato deleterio. Chi sottoscrive CDS per speculare non compra protezione ma piuttosto assume una posizione di vendita allo scoperto sulle emissioni della società oggetto di speculazione, di fatto scommettendo sul suo fallimento: in caso di default, infatti, lo speculatore riceverà dall’emittente del derivato un pagamento pari al nominale garantito.
Ma il circolo vizioso è più ampio: i contratti CDS sono un buon indicatore del premio per il rischio che il mercato richiede per mettere dei soldi nella società su cui vengono “scritti”: pertanto, quando aumenta la probabilità percepita di un fallimento, cresce il valore dei CDS, e con esso il costo dell’indebitamento per la società, in un avvitamento pernicioso e difficilmente controllabile.
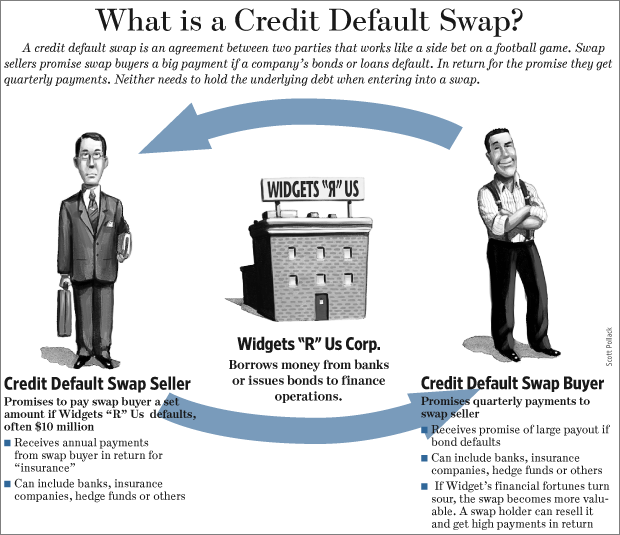 Ed è proprio questa l’accusa da parte dei politici europei nei confronti di molti Hedge Fund inglesi e americani. Questi operatori non bancari, che utilizzano di regola strategie molto sofisticate, hanno realizzato profitti astronomici scommettendo sulla bancarotta di società o Stati terzi (vedi la Grecia). Che il mercato dei CDS sia stato pesantemente “drogato” dalla speculazione è provato dal fatto che al momento dello scoppio della crisi il valore complessivo del mercato dei credit default swap ha superato (e di molto) quello della somma di tutte le obbligazioni nazionali, aziendali, e municipali in circolazione: l’eccedenza tra le due misure è costituita da quei titoli creati e sottoscritti per puri intenti “di scommessa”. Ad aggravare la situazione, i CDS vengono stipulati senza alcuna formalità, né per gli emittenti sono previsti particolari requisiti di capitale. E ora ci si ritrova con una pila di CDS conclusi sullo stesso sottostante.
Ed è proprio questa l’accusa da parte dei politici europei nei confronti di molti Hedge Fund inglesi e americani. Questi operatori non bancari, che utilizzano di regola strategie molto sofisticate, hanno realizzato profitti astronomici scommettendo sulla bancarotta di società o Stati terzi (vedi la Grecia). Che il mercato dei CDS sia stato pesantemente “drogato” dalla speculazione è provato dal fatto che al momento dello scoppio della crisi il valore complessivo del mercato dei credit default swap ha superato (e di molto) quello della somma di tutte le obbligazioni nazionali, aziendali, e municipali in circolazione: l’eccedenza tra le due misure è costituita da quei titoli creati e sottoscritti per puri intenti “di scommessa”. Ad aggravare la situazione, i CDS vengono stipulati senza alcuna formalità, né per gli emittenti sono previsti particolari requisiti di capitale. E ora ci si ritrova con una pila di CDS conclusi sullo stesso sottostante.
La Germania, che in questo momento di crisi ha assunto di fatto la leadership dell’Area Euro, sta lanciando segnali confortanti sul piano della lotta contro la speculazione basata sui derivati di credito. Tanto per dimostrare al mondo che la Cancelliera non solo abbaia ma è in grado anche di assestare qualche morso, la BaFin (CONSOB tedesca) ha annunciato ieri sera il divieto vendite allo scoperto su un paniere di titoli azionari di società assicurative e banche di importanza strategica (tra cui Allianz, Deutsche Bank e Commerzbank) nonché quello di negoziazione di “naked CDS”, ovvero CDS senza sottostante su titoli obbligazionari di emittenti sovrani (per impedire il tipo di giochino, per intenderci, che ha spacciato la Grecia).
Se l’idea alla base della decisione della BaFin è pienamente condivisibile sul piano del principio, non si può negare che essa è stata presa senza nemmeno preoccuparsi di consultare i Francesi, né Bruxelles, il che le ha conferito il poco gradevole stigma della disperazione. Il tutto senza contare che, da un punto di vista pratico non è ben chiaro il modo in cui l’autorità di vigilanza tedesca riuscirà a monitorare il rispetto del divieto da parte degli operatori, dato che la stragrande maggioranza delle transazioni sui derivati di credito continua ad essere negoziata su Londra.
La FSA, Financial Services Authority britannica si è tra l’altro affrettata a spiegare che il veto non potrà applicarsi alle filiali londinesi delle banche tedesche... Se poi si pensava di proteggere i titoli greci, si può concludere che la mossa è platealmente fallita, dato che lo spread sui titoli ellenici, proibizioni o no sui CDS, si è allargato di altri 37 centesimi.
Se gli Stati europei riusciranno a portare avanti un ordinamento del mercato finanziario senza il sostegno degli Stati Uniti è tutto da vedere: sarebbe un primo, indicativo passo verso un nuovo ottimismo nei confronti di un’economia capitalista che ha deluso i più. Certo, l’esordio gauchiste della Merkel non è dei più confortanti.
di Emanuela Pessina

