
Per oltre un decennio, fin dal fallimento dei colloqui negoziali di Camp David nel 2000, il mantra della politica di Israele è stato sempre lo stesso: «Non esiste alcun partner palestinese per la pace».
Questa settimana, la prima parte delle centinaia di documenti riservati palestinesi trapelati ha confermato i sospetti di un numero crescente di osservatori sul fatto che coloro che hanno un atteggiamento di rifiuto nel processo di pace sono da ricercarsi dal lato degli israeliani, non dei palestinesi.
Alcuni tra i documenti più rivelatori – pubblicati congiuntamente dalla televisione Al-Jazeera e dal quotidiano britannico Guardian – sono datati 2008, un periodo relativamente incoraggiante nei recenti negoziati tra Israele e i palestinesi.A quel tempo, Ehud Olmert era primo ministro di Israele e si era pubblicamente impegnato a cercare di raggiungere un accordo per uno Stato palestinese. Era spalleggiato dall’amministrazione degli Stati Uniti di George W. Bush, che aveva ravvivato il processo di pace alla fine del 2007 ospitando la conferenza di Annapolis.
In tali circostanze favorevoli – come mostrano i documenti – Israele respingeva una serie di importanti concessioni che il team negoziale palestinese aveva offerto nel corso dei mesi successivi in merito alle questioni più delicate presenti nei colloqui.
Mahmoud Abbas, presidente dell’Autorità Palestinese, ha cercato in maniera non convincente di negare l’autenticità di questi documenti, ma non gli ha giovato il fatto che i funzionari israeliani hanno fallito nel tentativo di correre in suo aiuto.
Secondo i documenti, il compromesso palestinese più significativo – o «svendita totale», come lo stanno definendo molti palestinesi – era su Gerusalemme.
Durante una serie di incontri lungo l’estate del 2008, i negoziatori palestinesi avevano concesso l’annessione da parte di Israele di vaste aree di Gerusalemme Est, inclusi quasi tutti gli insediamenti ebraici della città e anche parti della Città Vecchia.
Risulta difficile immaginare in che modo il collage risultante di enclavi palestinesi presenti a Gerusalemme Est – circondati da insediamenti ebraici – avrebbe mai potuto funzionare come capitale del nuovo Stato palestinese.
Al momento dei precedenti colloqui di Camp David, in base ai documenti ufficiali israeliani fatti trapelare dal quotidiano Haaretz nel 2008, Israele aveva proposto qualcosa di molto simile per Gerusalemme: il controllo palestinese su quelle che venivano al tempo chiamate «bolle» territoriali.
Nei colloqui successivi, i palestinesi avevano altresì dimostrato la volontà di poter rinunciare alla loro rivendicazione di sovranità esclusiva su Haram al-Sharif, la polveriera della Città Vecchia, il complesso sacro che include la moschea di Al-Aqsa, fiancheggiato dal Muro del Pianto. Al suo posto fu invece proposto un comitato internazionale di supervisione dell’area.
Questa è probabilmente stata la più grande concessione tra tutte quelle elargite dai negoziatori palestinesi, laddove – secondo un funzionario israeliano che era presente – proprio il controllo di Haram aveva fatto “saltare” i colloqui di Camp David.
Saeb Erekat, il capo negoziatore dell’OLP durante i colloqui, si dice abbia promesso ad Israele «la più grande Yerushalayim della storia» – usando la parola ebraica per Gerusalemme – da che il suo team aveva in effetti ceduto i diritti dei palestinesi sanciti dal diritto internazionale.
Le concessioni non finirono lì, in ogni caso. I palestinesi accettarono uno scambio di terra per ospitare il 70% del mezzo milione di coloni ebrei presenti in Cisgiordania compresa Gerusalemme Est e rinunciarono ai diritti di tutti, eccetto poche migliaia di rifugiati palestinesi.
Lo Stato palestinese doveva inoltre essere smilitarizzato.
In uno dei documenti registrati durante i negoziati nel maggio 2008, Erekat domanda ai negoziatori israeliani: «Senza considerare i vostri caccia nel mio cielo e il vostro esercito sul mio territorio, posso scegliere dove mettere al sicuro la mia difesa esterna?». La risposta israeliana fu un enfatico: «No».
È interessante notare che si dice che i negoziatori palestinesi abbiano accettato di riconoscere Israele come «Stato ebraico» – una concessione che adesso Israele sostiene sia uno dei principali ostacoli ad un accordo.
Israele aveva anche insistito affinché i palestinesi accettassero uno scambio di territori che avrebbe previsto la cessione di una piccola area di Israele al nuovo Stato palestinese insieme a ben un quinto dei 1,4 milioni di cittadini palestinesi israeliani. Questa pretesa riecheggia un controverso «trasferimento di popolazione» a lungo proposto da Avigdor Lieberman, il ministro degli esteri israeliano di estrema destra.
I Palestine Papers, come ora vengono chiamati, esigono una seria ri-valutazione di due persistenti – ed erronee – ipotesi teorizzate da molti osservatori occidentali circa il processo di pace.
La prima attiene al ruolo degli Stati Uniti auto-proclamatosi quale mediatore imparziale. Quel che in verità viene svelato dai documenti è la riluttanza dei funzionari USA ad esercitare pressioni eque sui negoziatori israeliani, sebbene fosse lo stesso team palestinese a proporre importanti concessioni su questioni centrali. Invece, le “richieste” di Israele erano sempre trattate come fondamentali.
Il secondo è la considerazione secondo cui i colloqui di pace sono falliti primariamente a causa della vittoria, alle elezioni di circa due anni fa, del governo della destra israeliana guidato da Binyamin Netanyahu. Questi ha provocato delle critiche da parte della comunità internazionale per aver rifiutato di impegnarsi, se non con dichiarazioni di circostanza, a sostenere la costituzione di uno Stato palestinese.
Lo scopo degli americani - almeno agli esordi dell'amministrazione Netanyahu - era quello di esercitare su di lui una forte pressione per far entrare nella sua coalizione Tzipi Livni, leader del partito centrista di opposizione Kadima. È grandemente stimata come la più credibile personalità israeliana votata per la pace.
Tuttavia, la Livni, che era stata precedentemente ministro degli Esteri di Olmert, nella documentazione riservata emerge come un'inflessibile negoziatrice, sprezzante delle enormi concessioni fatte dai palestinesi. Al punto cruciale della trattativa, rifiutò l'offerta palestinese dopo aver detto: «L'ho davvero apprezzata».
La questione decisiva per la la Livni fu il rifiuto dei negoziatori palestinesi di cedere a Israele una manciata di insediamenti nella Cisgiordania. I palestinesi si lamentarono a lungo del fatto che i due più significativi- l'insediamento fuori Gerusalemme, Maale Adumim, e quello di Ariel, vicino alla città palestinese di Nablus - avrebbero avuto l'effetto di scomporre la Cisgiordania in tre cantoni, togliendo speranza a qualsiasi chance di contiguità territoriale.
L'insistenza della Livni nel richiedere questi insediamenti - dopo tutti i compromessi prefigurati dai palestinesi - impone di pensare che non vi sia nessun leader israeliano preparato oppure in grado di portare a compimento un accordo di pace - a meno che, i palestinesi non cedano a qualsiasi richiesta israeliana e lascino da parte l'ambizione a uno Stato autonomo.
Uno dei "Palestine Papers" riferisce di un esasperato Erekat che un anno fa chiedeva ad un diplomatico USA: «Cosa posso dare di più?»
L'uomo con la risposta giusta potrebbe essere Lieberman, che, questa settimana, ha rivelato la sua mappa personale di un ipotetico Stato palestinese. In questa ipotesi veniva concesso uno statoprovvisorio che comprendesse meno della metà della Cisgiordania.
di Jonathan Cook - «The Electronic Intifada» - «The National».
 terroristi dall’annuale meeting dell’associazione privata World Economic Forum: la più ‘pubblica’ – e per questo la meno importante, ma anche la più esposta e quindi sorvegliata – tra le periodiche riunioni dell’élite globale. Un insolito articolo anonimo pubblicato proprio in questi giorni sull’Economist, dal titolo traducibile come “Le pause-caffè mondiali – Dove la gente che conta si incontra e parla”, descrive il forum svizzero di Davos, il suo equivalente asiatico di Boao in Cina, le riunioni del Council on Foreign Relations, della Commissione Trilaterale e del Bilderberg Group come importanti occasioni, tutte private ma più o meno riservate, nelle quali i “globocrati” della “élite cosmopolita” possono incontrarsi e dibattere in libertà i grandi temi mondiali e prendere decisioni che poi si traducono pratica, dalle guerre alle crisi finanziare.
terroristi dall’annuale meeting dell’associazione privata World Economic Forum: la più ‘pubblica’ – e per questo la meno importante, ma anche la più esposta e quindi sorvegliata – tra le periodiche riunioni dell’élite globale. Un insolito articolo anonimo pubblicato proprio in questi giorni sull’Economist, dal titolo traducibile come “Le pause-caffè mondiali – Dove la gente che conta si incontra e parla”, descrive il forum svizzero di Davos, il suo equivalente asiatico di Boao in Cina, le riunioni del Council on Foreign Relations, della Commissione Trilaterale e del Bilderberg Group come importanti occasioni, tutte private ma più o meno riservate, nelle quali i “globocrati” della “élite cosmopolita” possono incontrarsi e dibattere in libertà i grandi temi mondiali e prendere decisioni che poi si traducono pratica, dalle guerre alle crisi finanziare.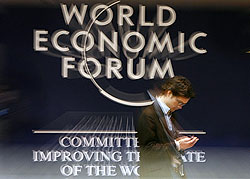 Bilderberg, o in privato a margine delle conferenze pubbliche, come succede invece al forum di Davos.
Bilderberg, o in privato a margine delle conferenze pubbliche, come succede invece al forum di Davos.